Filosofia della cultura
Molte voci, a più mani. Mechrí e le nuove mappe del pensiero
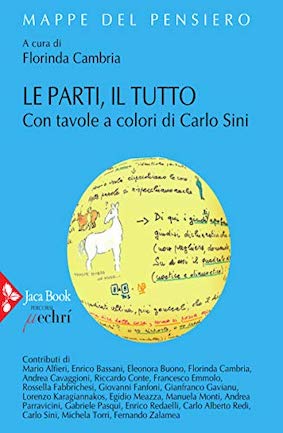
Oggi presentiamo un volume dal titolo Le parti, il tutto, pubblicato dalla Casa editrice Jaca Book nel gennaio di quest’anno. Il testo, curato da Florinda Cambria, raccoglie molte voci ed è stato scritto “a più mani”: non è un dettaglio, non è una curiosità, anzi è forse il tratto fondamentale dell’opera, ma non credo che riusciremo a sottolinearlo abbastanza. E chi l’ha scritto? Il “catalogo” è questo: Mario Alfieri, Enrico Bassani, Eleonora Buono, Florinda Cambria, Andrea Cavaggioni, Riccardo Conte, Francesco Emmolo, Rossella Fabbrichesi, Giovanni Fanfoni, Gianfranco Gavianu, Lorenzo Karagiannakos, Egidio Meazza, Manuela Monti, Andrea Parravicini, Gabriele Pasqui, Enrico Redalelli, Carlo Alberto Redi, Carlo Sini, Michela Torri, Fernando Zalamea.
Sì, sono venti, e in barba a qualsiasi strategia di marketing li abbiamo voluti inserire tutti, perché ciò che è decisivo in queste pagine è il loro dialogo, e – diciamolo pure – i loro litigi, perché “ha senso litigare solo con gli amici”, come scrivono Carlo Alberto Redi e Manuela Monti nel loro colloquio con Carlo Sini. Prendiamo la sezione dedicata alla “Forma”, vale a dire i materiali per un lemmario bio-filosofico, come pars pro toto, compiendo un’operazione che il libro stesso non cessa di denunciare come “atto sacrilego”, compiuto in realtà dall’intera tradizione occidentale.
Assistiamo a un dialogo sulla nozione di “Forma” tra i nostri interlocutori. Seguiamoli.
L’esordio è affidato a Carlo Alberto Redi e a Manuela Monti: “il processo del prendere forma del corpo umano è un continuum regolato dall’espressione epigenetica del genoma individuale e il risultato finale dipende dal contesto sociale, dall’interazione genoma-ambiente”. Poi ci spiegano l’accendersi e spegnersi di varie combinazioni all’interno dei nostri 30.000 geni, in grado di produrre fenocopie. Sulla base genetica vediamo innestarsi fenomeni di mimetismo sempre più complessi, che cominciano a tenere conto anche della morfologia dell’ambiente, sino ad arrivare a quel mimetismo che sorge e matura sul piano dell’interazione sociale. Di lì procedono con la fisiognomica, il rapporto tra forma e immagine, e altro ancora: è bello trovare citati nell’arco di poche pagine l’Atlante di Zoologia poetica di Poudebat e gli studi del biologo evoluzionista John Manning assieme a Roland Barthes, con la sua Camera chiara.
Ma è un attimo: l’idillio si spezza subito. Perché comincia il dialogo. “Il continuum dello sviluppo che sarebbe regolato dall’espressione epigenetica del genoma individuale”? Cosa, cosa? Ma i geni non possono “formare” o “informare”; il genoma non “regola”, non ha senso attribuire ad esso la capacità di regolare. Le parole sono di Sini, ma è la “voce di Nietzsche” che si può sentir risuonare là dentro: “Se noi, per nostra utilità di calcolo, sappiamo esprimere ciò in formule, in leggi, tanto meglio per noi! Ma noi non portiamo una “moralità” nel mondo per il fatto di fingerlo obbediente”. Sorge allora una richiesta precisa: dicano i biologi che cosa vedono accadere e che cosa poi li induce a usare la parola “informare”. Se la spiegazione parte sempre dal risultato del lavoro sperimentale, già codificato, e non dalla concretezza del lavoro che è in opera, allora – scrive Sini – “sarebbe come se qualcuno dicesse che le impronte sul terreno sono la causa delle gambe che camminando le producono”.
Insomma, non partiamo benissimo: senza mezzi termini, sembra quasi di assistere a un dialogo tra sordi! Ed è estremamente onesto ammetterlo: sulle prime non ci si capisce. Ma qui parte lo sforzo, da parte dei biologi, in mezzo a tutte le mille difficoltà – come se non sapessero, anche loro, che spesso ci mancano i concetti per esprimere certe relazioni: per comodità mettiamo una “parolina” che in effetti nasconde soltanto la nostra ignoranza, magari semplificando un po’ le cose. Sentiamo di nuovo l’eco di Nietzsche: “s’inventa un processo che sia afferrabile”.
Ci vuole sapienza, generosità, pazienza straordinarie per cominciare ad accorciare le distanze tra diversi saperi, tra differenti modalità di “scrittura del mondo”. Accorciarle non per ricomporle in unità armoniosa, non per raggiungere un nuovo consenso. “Ricomporre – scrive ancora Sini – non è la parola giusta”: ci mancano, ci mancano proprio le parole.
Figuriamoci quando Riccardo Conte introduce il problema della forma … ma nel diritto: non c’è un ambito del diritto che non ponga problemi inerenti alla forma. Le aporie vanno moltiplicandosi attraverso i testi di Cavaggioni, dedicati al concetto di forma nell’atto di conoscenza, e di Gianfranco Gavianu – dove sono chiamate a raccolta alcune tra le risorse più significative della cultura europea da Dante a Bruno, da Hegel a Goethe, da Varela a René Thom.
Forse un “piccolo inizio” viene suggerito da Kant, cui si ispirano gli interventi dello stesso Sini, di Rossella Fabbrichesi e di Andrea Parravicini: pensate alla regolarità del cinabro, che non è ora rosso, ora nero, altrimenti non si saprebbe nemmeno da dove cominciare. Ci dovrà pur essere una qualche stabilità nelle cose. Al contempo, però, Kant ci avverte in appendice al libro secondo della sua Analitica trascendentale che tutto ciò che noi conosciamo della materia si riduce a mere relazioni. Come dire, non ci sono le “cose”, le “proprietà”, i “soggetti”: bisogna inventarsi un modo nuovo di pensare per essere all’altezza di questa nuova concezione del mondo.
Ora moltiplicate tutto questo, per così dire, “alla n”: oltre al problema della forma, troverete un dialogo del medesimo calibro su vari argomenti come ad esempio: “Uno/molti”; L’arte del comporre; Linguaggi in transito: matematica; Costellazioni, e poi una discussione sul significato di transdisciplinare, e altre tematiche.
Ecco perché questo libro non poteva che essere scritto a più mani: la specializzazione scientifica ci ha resi tutti analfabeti rispetto a ciò che si trova oltre il millimetro quadrato del nostro ambito di conoscenza (che parola presuntuosa!). Lavorare in gruppo – ma in gruppi eterogenei, non soltanto in équipe perfettamente sincronizzate – dovrebbe essere un’esigenza ormai: certi “pezzi” del discorso che un giurista, un filosofo, o un critico letterario, vorrebbero imbastire avrebbero proprio bisogno del calcolo differenziale – ma lì ci vuole un matematico! – e non sarebbe male poter passare da un paragone con alcuni processi biologici – ma allora ci vuole proprio un biologo – e così via.
Forse, un libro come questo rappresenta in qualche modo anche un monito per il cosiddetto “lavoro filosofico”: davvero ha senso l’ennesima monografia su questo o quell’autore, su questo o quel tema? L’ennesimo volume in cui il singolo autore avrebbe la pretesa di mettere in ordine una complessità che lo travolgerà inevitabilmente?
Sono passati più di cent’anni ormai da quando Simmel denunciava come lo spirito oggettivo avesse raggiunto un ritmo di sviluppo rispetto al quale quello dello spirito soggettivo si trovava ad accusare un ritardo in rapido aumento. La riserva di prodotti dello spirito oggettivo cresce a perdita d’occhio e travolge l’individuo. Ora, è verissimo che non c’è cultura se il singolo non consegue e non acquisisce risultati oggettivi, ma è altrettanto vero che non c’è cultura se quei prodotti “non si fanno attraversare dal cammino che l’anima percorre da se stessa a se stessa”. Abbandonando ogni vacuo solipsismo, si tratterebbe di ammettere come un simile “percorso di soggettivazione” non possa che essere compiuto a più voci, a più mani. Altrimenti, non c’è cultura, e questa è esattamente la situazione che Simmel chiama tragedia. Tragedia – beninteso – non della cultura (che non c’è più), ma di ciò che rimane dopo la bancarotta della metafisica: la tragedia della nostra civiltà.