Filosofia della cultura
L’ingombro dell’io tra storia e narrazione
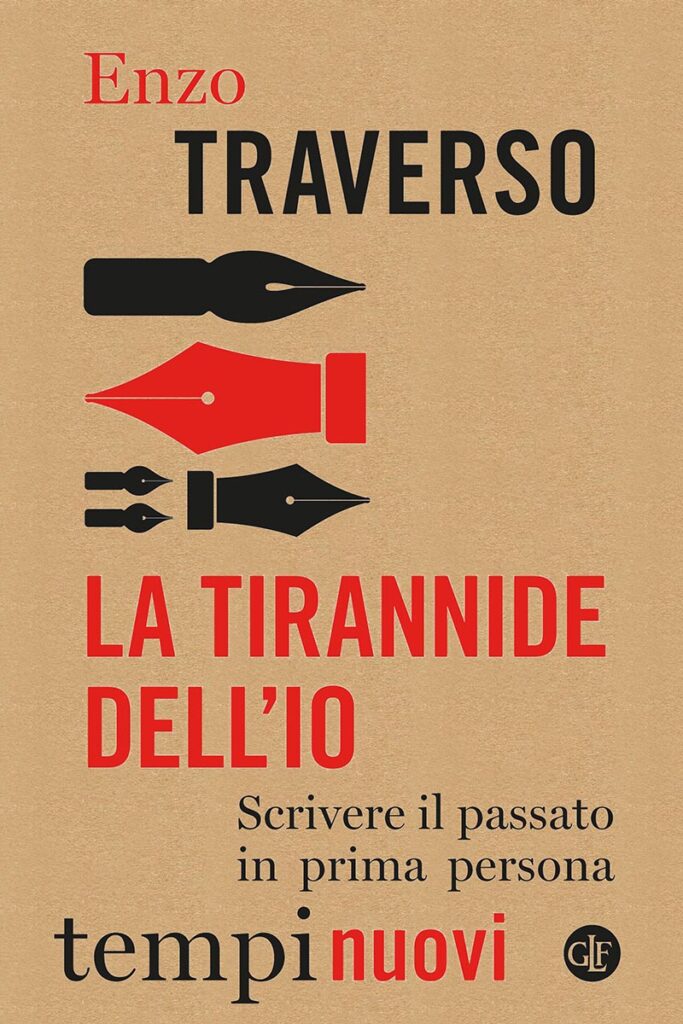
Il problema del rapporto tra la storia e la sua narrazione, tra Res Gestae e Historia rerum gestarum, chiama in causa categorie che non sono soltanto quelle del vero e del falso, ma anche del verosimile, del finto. Non è mancato chi, anche in Italia, ha tentato di mostrare il carattere fittizio di questo problema, dal momento che non si dà storia al di fuori della sua narrazione. Di più: nemmeno la narrazione, a rigore, esiste. Ad esistere è questa narrazione, quella di cui il lettore diventa autore nell’istante stesso in cui la legge e, leggendola, in certo senso la fa vivere. Non è qui il caso di soffermarsi sulle conseguenze problematiche che un così estremo scetticismo storico comporta. Da un punto di vista più strettamente storiografico, la questione si ridefinisce invece nel rapporto tra il contenuto narrato e l’io narrante. In gioco è dunque la soglia sfumata tra storia e testimonianza: l’una sfocia nell’altra quando lo storico dismette l’abito dell’analista e dice ‘io’, parlando in prima persona. È il tema dell’ultimo lavoro tradotto di Enzo Traverso, La tirannide dell’io. Scrivere il passato in prima persona (Laterza 2022, trad. it. di L. Falaschi). La disamina dell’autore prende le mosse dalla constatazione che sempre più frequentemente, negli ultimi quarant’anni, gli storici hanno trasgredito uno dei dettami prima ritenuti inviolabili della loro disciplina, quello dell’avalutatività, per introdurre nella loro opera la voce narrante, accompagnata dalle vicende personali, le sensazioni, le emozioni, le valutazioni individuali dello stesso storico scrivente. Del resto, il pregiudizio nei confronti dell’io ha una lunga storia. La regola autoimposta di Benjamin, ricordata da Traverso, di non usare mai la parola ‘io’ se non nelle lettere, potrebbe fare il paio con la famosa sentenza di Hegel secondo cui tutto ciò che di personale era presente nelle sue opere era da considerarsi falso. Vero è sì l’intero, ma un intero impersonale, non soggettivo. Il paradigma novecentesco dell’impersonalità che definisce per contrasto la tendenza degli storici a parlare in prima persona è rappresentato dalla Storia della Rivoluzione russa di Lev Trockij, in cui il rivoluzionario russo, pur servendosi di un armamentario archivistico costituito anzitutto da ricordi personali e vicende che lo hanno personalmente riguardato, non rinuncia alla terza persona.
Il processo di soggettivazione della narrazione storica non è privo di articolazioni interne e l’autore ne ripercorre le tappe attingendo ad uno straordinario archivio di autori, per lo più francesi, che ne hanno segnato i momenti decisivi. Dall’ “ego-storia” di Pierre Nora all’indagine di Jablonka sui “nonni che non ho avuto”, dal racconto autobiografico di storici di professione come Eric Hobsbawm e George Mosse alla tendenza degli storici contemporanei a «raccontare l’indagine». Riguardo a quest’ultima, richiamando l’opera di Carlo Ginzburg, l’autore individua nell’esibizione del «paradigma indiziario» una delle possibili declinazioni in positivo della storia scritta in prima persona. Il racconto storico cessa di essere la messa in parola di un intreccio di pratiche archivistiche che rimangono nascoste per far posto alla loro esibizione.
Non si rischia, rinunciando all’impersonalità del resoconto storiografico, di sfumare sempre più, fino quasi a confonderli, i confini tra narrazione storica e racconto di fantascienza, tra verità e finzione, saggio storico e romanzo? Traverso affronta la questione mostrando, anche in questo caso attraverso una notevole quantità di esempi, come l’intreccio tra questi due poli non comporti necessariamente l’esclusione di uno dei due a vantaggio dell’altro. Si veda Il nome della rosa di Umberto Eco, in cui l’erudizione storica dell’autore è accompagnata dalla capacità di costruire intrecci narrativi avvincenti che abbiano come criterio il “verosimile”. Se in Germania tale paradigma stilistico è ben incarnato dal romanzo storico di Hans Magnus Enzensberger Hammerstein o dell’ostinazione, dedicato al generale tedesco che nel 1934 rinunciò al proprio ruolo per manifestare la propria avversione a Hitler, in Italia è con M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati che l’articolazione tra storia e invenzione narrativa ha recentemente trovato una delle sue espressioni più riuscite.
L’autore può quindi difendere il concetto di una verità fattuale che lo storico francese Pierre Vidal-Nacquet, impegnato a contrastare il negazionismo, indicava come «qualcosa di irriducibile che, in mancanza di espressioni migliori, continuerò a chiamare il reale». Non si tratta della presa di posizione in difesa di un ingenuo realismo, di quell’ «illusione fattografica» che vede nell’archivio, nella fonte, per l’appunto un “fatto” inquestionabile, quanto piuttosto del riconoscimento del paradosso costituito da un reale che, per quanto reso operativo solo dal lavoro dello storico, rimane nondimeno l’irriducibile presupposto della sua stessa indagine, una sorta di apriori storico, un rapporto di incessante rimando ed esclusione tra sostrato archeologico e prassi interpretante.
Nell’ultimo capitolo, Traverso rende esplicite le proprie riserve critiche nei confronti dell’analizzata tendenza della storiografia contemporanea a parlare in prima persona, mettendo in guardia contro il pericolo di ridurre il passato ad una polverosa collezione di ricordi intimi ed individuali, incapaci di alimentare una memoria collettiva, sorgente di ogni grande cambiamento storico. La diagnosi di Traverso è che la Geschichte rischi di frantumarsi in un ginepraio di Historien: «La grana della storia s’ingrossa nella misura in cui il quadro d’insieme si sfoca; la dilatazione dei dettagli ha reso incomprensibile la sequenza. Le nuove scritture soggettiviste della storia sono uno dei sintomi di questa Sattelzeit rovesciata». Ciò non implica l’invito a riattivare l’istanza storicista, incapace di mettere in dialogo macro e microstoria. Semmai, evocando Kracauer, l’autore invita ad assumere una prospettiva in grado di «procedere attraverso dei colpi di sonda nel passato, alternando piani sequenza (long shots) e primi piani (close-ups) […] Il piano sequenza è il metodo di Arnold Toynbee e Fernand Braudel (ripreso oggi da Jürgen Osterhammel), fautori della “lunga durata” e della storia strutturale. Il primo piano è invece utilizzato da Erwin Panofsky (e oggi da Carlo Ginzburg)».
La metafora cinematografica non potrebbe meglio esemplificare la questione di pensiero che il testo solleva. Nel problema del rapporto tra l’evento storico e la forma narrativa con la quale testimoniarlo, ad essere in gioco è la giuntura tra dialettica storica e messianismo, continuità e interruzione, la mancata articolazione dei quali ha talvolta schiacciato la storiografia su posizioni ideologiche, animate da cieche fedi nelle magnifiche sorti e progressive dell’umanità o in affrettate diagnosi di fini della storia. Fedeltà alla dimensione politica della storia e rivendicazione dello spazio del “noi” di là dalle (pur legittime) rivendicazioni dell’ “io”: queste, in sintesi, le sfide della storiografia a venire.